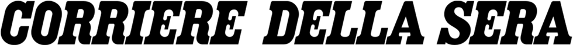Regali e convenevoli
di Nicola Belcari - Martedì 14 Settembre 2021 ore 11:27

Nei sinonimi dono/regalo non si distinguono due (o tre?) significati principali diversi: l’omaggio dovuto, la grazia beneficio, lo scambio obbligante; ed è difficile assegnarli all’una o all’altra parola. Nell’uso odierno, dono ha una connotazione di nobiltà e letterarietà che la rende impegnativa, mentre regalo è più prosaica e comune, anche se non mancano eccezioni.
La “casistica” è sterminata: dai doni dei Magi, estremo riconoscimento di una superiore regalità al dono malefico o d’incerta bontà: Pandora, il cavallo di Troia (“Timeo Danaos…”), il pomo della discordia, la veste di Medea, la mela avvelenata, ecc.
Il dono era un’importante istituzione sociale nella Grecia antica e mitica (stabiliva un legame profondo e duraturo tra ospiti), oggi la sua pratica è spesso impoverita e immiserita, come stanca convenzione.
Si va dalle rose rosse del romantico spasimante alla “lista-regali”; dal riciclaggio esplicito o celato a seconda della confidenza (badando a non restituire a chi ha donato) alla possibilità di cambiare l’oggetto con lo scontrino.
La battuta più divertente (sentita in un film) è di un giovane che ricevendo un pacchetto, vista la forma, non si fa scrupoli di esprimere il proprio timore: “Non sarà mica un libro?! A casa ne ho già uno.”
C’è un frasario di circostanza. “È un pensierino” (si giustifica l’esiguità del valore economico) in effetti “conta il pensiero”. “Presente” è termine che ricorda il donatore e pure un esserci segno d’affetto. “A caval donato…” (a patto di potersene disfare se ingombrante) ecc.
Tra parenti (e conoscenti) sono modi di dire diffusi, si ripetono ormai come formule stereotipate e se possono infastidire quando il tono è pretenzioso, si dovrebbero accettare con indulgenza per le buone intenzioni che li motivano. A volte hanno il carattere di vuotezza e insignificanza che li rende puro rumore.
Appartiene alla sfera di tali rapporti con gli altri l’invito. “Venite a pranzo domenica? Non per il mangiare, si fa per stare insieme…” Chi si rivolge così o nasconde intenzioni occulte o non si rende conto di proferire una minaccia. Per tranquillizzare l’interlocutore dovrebbe dire: “Venite a pranzo. Non si fa per stare insieme, ma solo per mangiare” per consumare cioè un pranzetto un po’ più ricco o prelibato del solito.
Tutti sappiamo, infatti, quanto sia deludente quello stare insieme, come la conversazione si svolga senza dire niente e come, se davvero si cercasse di comunicare qualcosa, ammesso che fosse possibile non farsi scoraggiare dai segnali d’inopportunità, fino al visibile sgomento, di un simile tentativo, si rischierebbe di provocare delle spiacevoli situazioni: dal sentirsi un imbecille di fronte all’altrui imbarazzo, alla disapprovazione che non sfocia in una sana discussione, ma nel disprezzo di essere ignorati. Peggio è solo quando la reazione consiste in una tacita congiura dei convitati che trattano il ribelle come “testa di turco” e a costui non resta che subire per amor di pace o quieto vivere.
I regali (corollario di quelle riunioni) non possono mancare in occasione delle feste, delle ricorrenze o eventi personali e sono una consuetudine a fin di bene.Il dono di sé, come offerta di conoscenza, e l’accoglienza gradita di chi lo riceve e lo contraccambia, sarebbe il regalo più vero, ma pazienza...
Il dono offerto sta, nel doppio valore di star dentro e consistere, nella carta da regalo con i suoi fiori colorati e nel fiocco che la chiude: accartocciato da una parte l’involucro e sciolto e abbandonato il nastro, finisce la sorpresa e il fascino, immagino.I “regali”, metafora dei comportamenti, che si scambiano le persone, sono purtroppo non di rado indifferenza, scortesia, malignità, di solito ben infiocchettate da ipocrisia e dissimulazione; tutti rigorosamente gratis e reciproci, perché per loro natura obbligano la restituzione.
Le ovvietà di quelle situazioni sono ormai talmente logore e abusate da essere andate in crisi anche tra i più accaniti sostenitori. “Non ti dovevi disturbare”, “Non importava”, “è proprio quello che desideravo”, “Chissà quanto ti sarà costato” (con simulato accenno di preoccupazione). Il canovaccio è arcinoto e nessuno quasi lo recita più, a parte qualche attardato nostalgico.
La difficoltà sta nell’interpretazione. Non c’è pericolo di dimenticare la battuta ma è l’espressione che conta: ripetere con una cantilena tutta la sfilza senza sentimento avrebbe l’effetto di un’offesa gratuita, come il dono.
Immaginate, invece, se qualcuno dicesse: “Ma cos’è questo troiaio?” “Ho sempre detestato oggetti come questo”, “Non fa per me”, ecc. Ma qui stiamo sul confine sottile tra la sincerità e la maleducazione. Un esempio illustre da non imitare è il Misantropo di Molière.
Il repertorio, quindi, dovrà essere rinnovato in modo che la forma sia diversa ma immutato il contenuto. Non è semplice. Un’espressione ormai collaudata tra i giovani alla moda è “Wow” (pronuncia uào, con un’acca finale facoltativa) con la faccia atteggiata a meraviglia o contentezza. “Fantastico!” può andare per coloro di mezz’età, mentre per i vecchi non si sa cosa suggerire, di credibile. Ma è, comunque, sempre in agguato la figura del “coglione” (dal provenzale, Leopardi e altri, soprattutto poeti).
Un giorno ci pentiremo di tutto questo.
Nicola Belcari